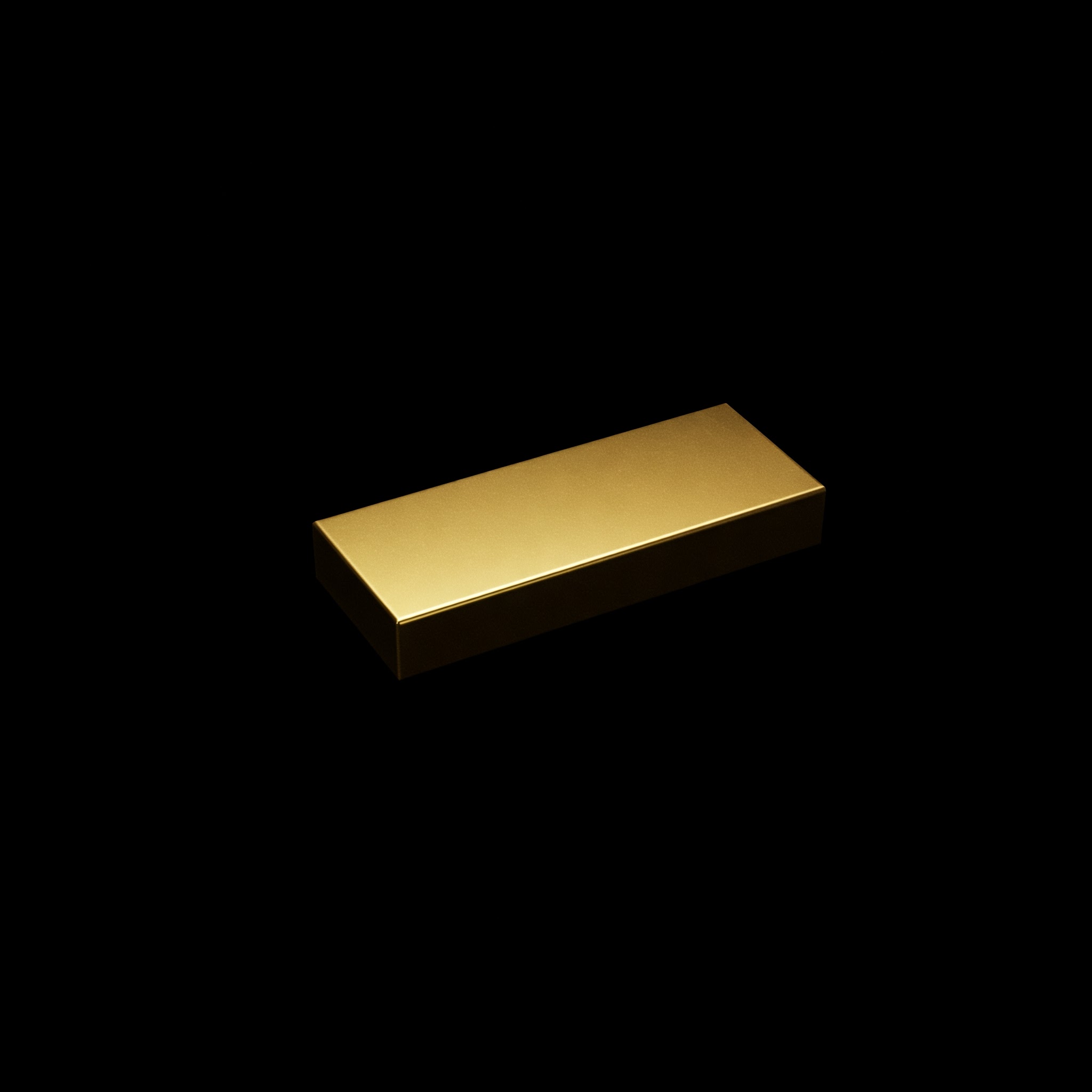English version
No, il privilegio non è una sorta di peccato originale. Al massimo, come scrive Paul Graham in questo post, può sembrare tale in certi ambienti woke delle metropoli californiane. In quei contesti nascere con un determinato sesso, colore della pelle o orientamento sessuale può venire talvolta percepito come un privilegio di per sé.
Ma basta riflettere un attimo per capire che il privilegio non è l’identità che ci è data alla nascita, bensì le conseguenze che questa identità comporta.
Queste conseguenze si muovono in due direzioni: dall’esterno verso l’interno e viceversa. Non è solo la società, con le sue istituzioni, convenzioni e pregiudizi, a confermare e rafforzare il mio privilegio. Sono anche io, spesso senza accorgermene, a sfruttarlo e consolidarlo attraverso le mie opinioni, azioni e abitudini. Ma soprattutto attraverso una percezione della realtà determinata almeno in parte proprio da quel privilegio.
Qui il punto chiave è che in molti casi non si tratta di un processo volontario o cosciente. Il privilegiato è portato non soltanto a giudicare il mondo in un determinato modo, ma anche a percepirlo a partire da coordinate condizionate dalla prospettiva del suo privilegio. Sulla base di queste percezioni costruisce i suoi giudizi.
Un uomo, ad esempio, sarà meno abile di una donna a percepisce le manifestazioni strutturali del sessismo, sia quelle della società sia le proprie, perché non è cresciuto subendole. Per sua fortuna, non si è mai trovato – o è successo di rado – nella condizione di dover mettere in discussione, in modo profondo e sincero, l’esistenza stessa di quel sessismo.
Facciamo un altro esempio: qual è la prima cosa che guardi quando devi prenotare un alloggio per una vacanza, un B&B o un albergo, per esempio? La risposta a questa domanda potrebbe essere molto diversa a seconda della tua identità, e soprattutto delle componenti di privilegio o vantaggio sociale che questa identità si porta dietro.
Per un gruppo di adolescenti è possibile che la probabilità che la risposta sia “il prezzo” sia inversamente proporzionale al reddito o al patrimonio dei genitori. Una persona costretta su una sedia a rotelle, invece, si assicurerà per prima cosa che non sia necessario fare le scale.
O ancora: l’impianto urbanistico di una città cambia a seconda del genere sessuale di chi lo vive. Per ogni donna che leggerà queste righe sarà un’ovvietà il principio per cui la luminosità di una strada è un criterio molto più rilevante della lunghezza nello scegliere il tragitto per tornare a casa a piedi la sera. Un uomo potrebbe forse ancora recepire questo concetto con una certa sorpresa.
Si può discutere su quanto ciascuno sia responsabile del proprio privilegio, su cosa dovrebbe farci e se debba farci qualcosa. Ma prima di tutto è fondamentale definirlo correttamente: il privilegio non è solo il numero e la natura delle opportunità che si spalancano grazie a un’identità piuttosto che a un merito, ma anche la libertà di ignorare un problema. È la possibilità di non vedere i punti ciechi nelle proprie opinioni e nei propri comportamenti.
Ogni volta che ho fatto notare a qualcuno l’ingiustizia intrinseca del suo operato – e questo vale anche per me, in quanto classico privilegiato – la reazione più comune è stata il rifiuto. Ci avviluppiamo in ragionamenti retorici pur di non ammettere di aver agito da una posizione di vantaggio, magari commettendo un’ingiustizia per automatismo o inconsapevolezza.
Eppure, se crediamo che una società più equa sia anche una società migliore – per tutti e da ogni punto di vista – dobbiamo imparare a riconoscere e superare questo riflesso istintivo di difesa, rifiuto e negazione. A volte basta semplicemente chiedere scusa e fare tesoro della lezione.
Ma dubito che andremo in questa direzione. Poiché in alcuni contesti – qualche campus americano, qualche magazine di San Francisco – il privilegiato è dipinto come un mostro, diventa fin troppo facile, per chi gode di un privilegio, sentirsi attaccato ogni volta che gli si fa notare qualcosa, qualunque essa sia. Così ci ritroviamo di fronte alla tipica scena di vittimizzazione: in un acrobatico rovesciamento delle parti, il privilegiato si presenta come vittima. Complotto, accanimento, gogna: parole facili da sventolare quando viene denunciata un’ingiustizia o, quanto meno, una posizione discutibile sul piano pubblico. Ma, ancora più spesso, il meccanismo della vittimizzazione si attiva anche sul piano privato, rendendo impossibile qualsiasi confronto onesto.
Eppure, riconoscere il privilegio non significa accettare una colpa personale, né tantomeno essere condannati a un’eterna penitenza. Significa, piuttosto, sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità rispetto al proprio posto nel mondo e alle dinamiche che lo plasmano. Comprendere il privilegio permette di agire con maggiore empatia, di ascoltare esperienze diverse dalle proprie senza sentirsi automaticamente sotto accusa, di contribuire – con piccoli o grandi gesti – a una società più giusta.
Il vero obiettivo non è la colpevolizzazione, ma la costruzione di uno spazio comune in cui il dialogo sia possibile e in cui il riconoscimento del privilegio non sia vissuto come una minaccia, bensì come un’occasione per ampliare la propria visione del mondo. Forse non potremo mai liberarci del tutto dei condizionamenti che il privilegio impone sul nostro modo di vedere la realtà, ma possiamo almeno impegnarci a non essere ciechi di fronte alle sue conseguenze.
Immagine in evidenza generata con Google Imagen 3 – Gemini